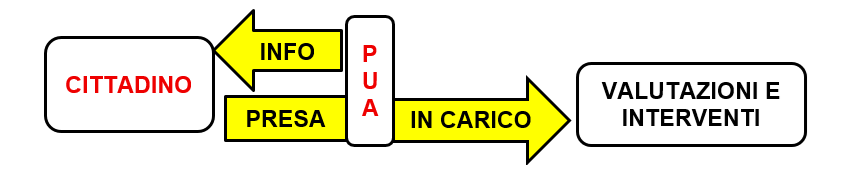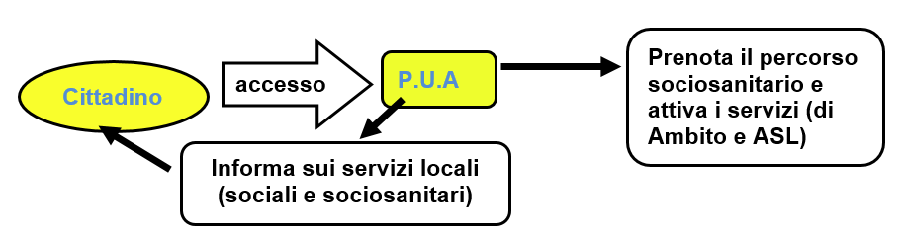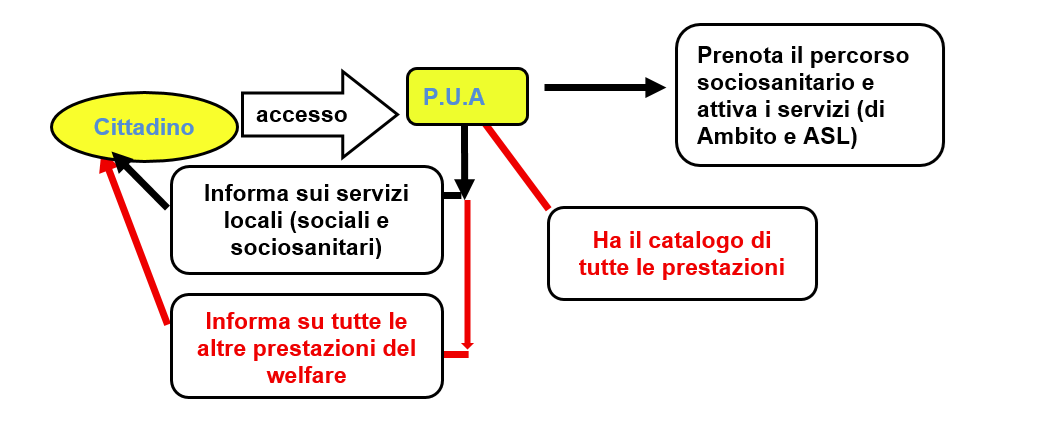Cookie Policy di welforum.it
Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a questa Applicazione di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando quest’ultimo interagisce con questa Applicazione.
Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite “Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare.
Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, sarebbe fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, dal momento che si tratta di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il termine Cookie è utilizzato solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento.
Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento.
Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente.
In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante - quale la presenza di altri Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link messi a disposizione) o contattando il Titolare.
Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di questa Applicazione e la fornitura del Servizio
Questa Applicazione utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento o la fornitura del Servizio.
Strumenti di Tracciamento di terza parte
- Gestione dei tag
Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questa Applicazione.
L'uso di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.
- Protezione dallo SPAM
Questo tipo di servizi analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Ireland Limited.
L'utilizzo del sistema reCAPTCHA è soggetto alla privacy policy e ai termini di utilizzo di Google.
Dati Personali trattati: clic, Dati di utilizzo, eventi keypress, eventi relativi ai sensori di movimento, eventi touch, movimenti del mouse, posizione relativa allo scorrimento, risposte alle domande e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.
Durata di archiviazione:
_GRECAPTCHA: durata della sessione
rc::a: non definita
rc::b: durata della sessione
rc::c: durata della sessione
Altre attività che prevedono l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento
Miglioramento dell’esperienza
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire una user experience personalizzata, consentendo una migliore gestione delle impostazioni personali e l'interazione con network e piattaforme esterne.
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti non lo utilizzano.
Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questa Applicazione non vengano ricollegati al profilo dell'Utente.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Durata di archiviazione:
- personalization_id: 2 anni
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Durata di archiviazione:
- AnalyticsSyncHistory: 1 mese
- JSESSIONID: durata della sessione
- UserMatchHistory: 1 mese
- bcookie: 1 anno
- bscookie: 1 anno
- lang: durata della sessione
- lidc: 1 giorno
- lissc: 1 anno
- lms_ads: 1 mese
- lms_analytics: 1 mese
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Meta Platforms, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Meta Platforms, Inc.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumento di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Stati Uniti - Privacy Policy
Durata di archiviazione:
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
-
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano.
Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy.
Misurazione
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli Utenti con l'obiettivo di migliorare il Servizio.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)
Google Analytics è un servizio di statistica fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
In Google Analytics 4, gli indirizzi IP vengono utilizzati al momento della raccolta e poi eliminati prima che i dati vengano registrati in qualsiasi data center o server. Per saperne di più, è possibile consultare la documentazione ufficiale di Google.
Dati Personali trattati: città, Dati di utilizzo, informazioni sul browser, informazioni sul dispositivo, latitudine (della città), longitudine (della città), numero di Utenti, statistiche delle sessioni e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.
Durata di archiviazione:
- _ga: 2 anni
- _ga_*: 2 anni
Targeting e Pubblicità
Questa Applicazione utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali personalizzati in base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e tracciare annunci pubblicitari.
Alcuni dei servizi utilizzati dal Titolare aderiscono al Transparency and Consent Framework di IAB, un’iniziativa che promuove pratiche responsabili di trattamento dei dati nel settore della pubblicità digitale ed assicura agli Utenti maggior trasparenza e controllo sull’utilizzo dei propri dati a scopo di tracciamento pubblicitario. Gli Utenti possono esprimere le proprie preferenze riguardo ai servizi pubblicitari in qualsiasi momento accedendo al pannello delle impostazioni di tracciamento della pubblicità direttamente dall'informativa sui cookie oppure tramite l'apposito link su questa Applicazione.
Questa Applicazione aderisce al Transparency and Consent Framework di IAB ed adempie alle relative Specifiche e Politiche. Questa Applicazione utilizza iubenda (numero identificativo 123) come software per la gestione del consenso (“Consent Management Platform”).
Remarketing e behavioral targeting
-
Questo tipo di servizi consente a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione da parte dell'Utente.
Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behavioral targeting.
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.
Generalmente i servizi di questo tipo offrono la possibilità di disattivare tale tracciamento. Oltre a qualsiasi funzione di opt-out fornita da uno qualsiasi dei servizi elencati in questo documento, l’Utente può leggere di più su come disattivare gli annunci pubblicitari basati sugli interessi nell'apposita sezione "Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi" in questo documento.
Google Signals (Google Ireland Limited)
Questa Applicazione utilizza Google Signals, una funzionalità di Google Analytics che associa le informazioni sulle visualizzazioni raccolte da questa Applicazione con le informazioni di Google provenienti dagli account degli utenti Google che hanno acconsentito a questa associazione per la personalizzazione degli annunci. Queste informazioni Google possono includere la posizione dell'Utente, la cronologia delle ricerche, la cronologia di YouTube e i Dati provenienti da siiti partner di Google e vengono utilizzate per fornire informazioni aggregate e anonime sui comportamenti trasversali degli Utenti.
Se un Utente rientra nella associazione sopra descritta, potrà accedere e/o eliminare tali Dati attraverso la funzione MyActivity fornita da Google.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo e Strumenti di Tracciamento.
Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.
Come gestire le preferenze e prestare o revocare il consenso
Esistono vari modi per gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento e per prestare o revocare il consenso, ove necessario:
Gli Utenti possono gestire le preferenze relative agli Strumenti di Tracciamento direttamente tramite le impostazioni dei propri dispositivi - per esempio, possono impedire l’uso o l’archiviazione di Strumenti di Tracciamento.
In aggiunta, ogni qualvolta l’utilizzo di Strumenti di Tracciamento dipenda da consenso, l’Utente può prestare o revocare tale consenso impostando le proprie preferenze all’interno dell’informativa sui cookie o aggiornando tali preferenze tramite il widget delle impostazioni di tracciamento, se presente.
Grazie ad apposite funzioni del browser o del dispositivo è anche possibile rimuovere Strumenti di Tracciamento precedentemente salvati.
Altri Strumenti di Tracciamento presenti nella memoria locale del browser possono essere rimossi cancellando la cronologia di navigazione.
Per quanto riguarda Strumenti di Tracciamento di terza parte, gli Utenti possono gestire le preferenze e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattandola direttamente.
Individuare le impostazioni relative agli Strumenti di Tracciamento
Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi:
Gli Utenti possono inoltre gestire alcuni Strumenti di Tracciamento per applicazioni mobili disattivandoli tramite le apposite impostazioni del dispositivo, quali le impostazioni di pubblicità per dispositivi mobili o le impostazioni relative al tracciamento in generale (gli Utenti possono consultare le impostazioni del dispositivo per individuare quella pertinente).
Come disattivare la pubblicità basata sugli interessi
Fermo restando quanto precede, si informano gli Utenti della possibilità di avvalersi delle informazioni presenti su YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite nel presente documento.
La Digital Advertising Alliance mette inoltre a disposizione un’applicazione chiamata AppChoices che aiuta gli Utenti a controllare la pubblicità comportamentale sulle applicazioni mobili.
Conseguenze del rifiuto del consenso
Gli Utenti sono liberi di decidere se prestare o meno il consenso. Tuttavia, si noti che gli Strumenti di Tracciamento consentono a questa Applicazione di fornire una migliore esperienza e funzionalità avanzate agli Utenti (in linea con le finalità delineate nel presente documento). Pertanto, in assenza del consenso dell'Utente, il Titolare potrebbe non essere in grado di fornire le relative funzionalità.
Titolare del Trattamento dei Dati
Associazione per la Ricerca Sociale
Via Venti Settembre, 24
20123 Milano
Indirizzo email del Titolare: redazione@welforum.it
Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su questa Applicazione non può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo documento.
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie su questa Applicazione.